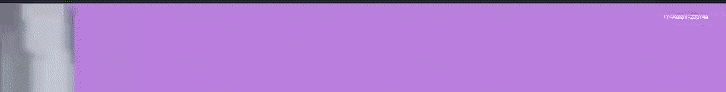Si fa presto a dire ripartiamo, e nemmeno ci vuole molto a parlare di nuova classe dirigente e di ricambio generazionale. Tra silenzi imbarazzati e dichiarazioni elusive, da quando nel PD di Latina è scoppiato il caso Moscardelli quei pochi che intervengono non fanno altro che annunciare buoni propositi e belle intenzioni.
Ma senza un tentativo di analisi e di approfondimento che vada al di là dei casi personali, quei buoni propositi e quelle belle intenzioni valgono a poco, fanno anzi pensare ad un rituale di cannibalismo politico di cui non mancano illustri precedenti.
Ripartire? Per dove? Una nuova classe dirigente? Quale? Un ricambio generazionale? Con chi?
Perché non provare allora ad allontanarsi un po’ dalla polemica più immediata, dal quotidiano diluvio di parole sparse sui social per comprendere le cause di quella vicenda?
La moralità della politica.
L’arrogante ceto politico che ha governato l’Italia nell’ultima fase della Prima repubblica, dall’assassinio di Aldo Moro in poi, ha la responsabilità storica di aver badato solo ai suoi giochi di potere, senza curarsi affatto di interpretare il profondo malessere che ribolliva nella società. Con il risultato di aver creato le condizioni di quel rivolgimento che fu Mani pulite, il giustizialismo e il predominio della magistratura sulla politica, costretta a rintanarsi e a camuffarsi dietro nuovi simboli e nuove sigle.
Nella Seconda repubblica la politica è diventata pura tattica, con le nuove forze politiche, sensibili quasi solo ai quotidiani sondaggi e sempre pronte a cavalcare le pulsioni che provenivano dal basso per guadagnare consensi, senza alcuna capacità di distinguere e separare il grano dal loglio per rispondere alle giuste esigenze che quelle pulsioni manifestavano e, al contempo, per assorbire e neutralizzare quelle insensate e irrazionali. Senza svolgere insomma la funzione vera della politica: interpetare e rispondere ai bisogni della società, integrando nelle istituzioni democratiche i ceti più deboli, senza pedagogismi, ma cambiando nei fatti le loro condizioni di vita.
En passant, ma forse la questione meriterebbe una seria riflessione: è dalla Seconda repubblica che il tasso di crescita della società italiana è costantemente inferiore a quello della media UE. Solo una casuale coincidenza o la conseguenza del prevalere, almeno nella pubblica amministrazione (che tuttavia è un fattore non del tutto secondario della crescita economica), di un procedimentalismo di carattere formale indifferente alla concretezza dei risultati e pensato solo per evitare qualsiasi tipo di responsabilità soggettiva?
Il fallimento del ceto politico della Seconda repubblica (chi non ricorda i cantori dei fasti del bipolarismo?) ha poi determinato il fenomeno pentastellato, responsabile di grandi mistificazioni che è difficile riassumere (non riesco però a dimenticare l’obbrobrio di voler presentare a Mattarella il governo M5S prima, prima dico, delle elezioni del 2018). Di quelle mistificazioni ve n’è una, quella della democrazia diretta, che implicitamente continua a perseguitarci ancora oggi con il richiamo non del tutto innocente all’agorà, lo spaziio pubblico della polis greca ove i cittadini si riunivano, discuteva e decidevano. Quale ripasso della storia, quali letture consigliare per far comprendere quello che dovremmo sapere ormai da più di due secoli, che la democrazia dei moderni è quella rappresentativa? Un’altra mistificazione c’interessa qui da vicino: l’idea che la moralità della politica consista nella moralità dei politici. Un’idea miserevole che butta a mare secoli di riflessione e di teoria della politica e inganna i gonzi per garantire ai sacerdoti della pubblica morale posizioni di potere, influenza e vendite di carta stampata. Domanda: come si fa a garantire la moralità dei politici? Facendo loro ogni giorno un tampone per verificare che nelle ultime ventiquattr’ore non siano sati infettati dal virus della corruzione? Ripristinando il costume delle denunce anonime in uso nella sospettosa Repubblica di Venezia? Affidandosi all’occhiuta sorveglianza che durante il ventennio fascita era commissionata ai portieri dei caseggiati?
La moralità della politica è ben altro, è una cosa più seria e complicata, come sono tutte le cose complicate: essa non parla di purezza d’animo e di cuori impavidi, consiste invece, almeno per una forza di sinistra seriamente riformista, nel comprendere e interpretare i bisogni della società, nel lottare per il miglioramento delle condizioni di vita ed economiche dei più deboli, nel modificare gli assetti istituzionali per renderli più efficaci, nel garantire la buona amministrazione per avere insomma una società più giusta. E, riguardo alla questione dell’onestà, per affidare l’onestà delle istituzioni a congegni semplici e affidabili che consentano di controllare facilmente i risultati dell’attività di governanti e amministratori.
Certo, sono principi e orientamenti generali che hanno bisogno di essere tradotti in azione politica, in obiettivi di breve, medio e lungo termine, ma un’analisi scevra da pregiudizi, paraventi ideologici e tatticismi di corto respiro non faticherebbe molto a ricavare da essi le linee d’azione e le iniziative da intraprendere.
Leggi elettorali
Nessuno ne parla, ma tutti ci pensano alla legge che regola le elezioni politiche. Cambiata non so più quante volte negli ultimi anni, sempre con l’intento furbesco di “fregare” l’avversario di turno, la legge elettorale è il motore del “sommerso politico”. Ma rimanendo entro l’ambito del funzionamento delle istituzioni, che non è affatto tutto il campo della politica (chi lo pensa è contagiato dal “cretinismo parlamentare”), la questione della o delle leggi elettorali è anche uno degli esempi emblematici del tipo di analisi che sarebbe opportuno svolgere.
La legge che regola l’elezione dei sindaci (ma il discorso potrebbe valere anche per l’elezione dei presidenti di regione) è maggioritaria e prevede l’elezione diretta. È il risultato di quel cambiamento di sistema che si ebbe con la Seconda repubblica, quando prevalse l’idea che il decisore politico, messo al riparo dai mutevoli giochi dei cambi di maggioranza, potesse amministrare meglio ed essere giudicato dagli elettori al termine del mandato per i risultati conseguiti. Sono forse proposizioni che hanno una qualche validità per le metropoli, ove il gran numero di elettori è difficilmente scomponibile in tante particolarità e la proposta politica più affidabile può emergere senza essere offuscata dalla moltitudine degli interessi corporativi. Ma nelle piccole città, dove concorrono molte liste civiche dall’incerto profilo politico e un numero spropositato di candidati, quasi uno per ogni condominio, non prevarranno forse i particolarismi? Non vincerà chi riuscirà a mettere insieme tanti pezzi eterogenei, ognuno portatore di propri interessi particolari?
La personalizzazione della lotta elettorale e il sistema maggioritario, che consente di vincere solo per pochi voti, non riguardano solo l’elezione dei sindaci (e dei presidenti di regione), sono fattori non secondari anche del meccanismo che regola le elezioni politiche.
Sono fattori che per loro natura estremizzano la competizione: uno di qua, l’altro di là, separati da un mare di propaganda e di ingiurie che rende poi difficile, se non impossibile, la mediazione, il compromesso tra le parti in campo, tutto quello che una rozza narrazione qualifica come inciucio ed è invece una componente di quella dialettica politica (di cui naturalmente fa parte anche l’aspra contrapposizione) che nei momenti migliori della storia repubblicana ha dato ottima prova di sé (tra l’altro: la fase contituente, la lotta al terrorismo, ma per la Seconda repubblica non mi viene in mente nessun altro esempio).
Sono, queste, considerazione che attengono al lato oggettivo della questione, ma che dire se riguardiamo al suo lato soggettivo? Non vedremo altro che un’accolita di candidati che fanno gruppo per prevalere, anche per pochi voti, sugli avversari. Poi, se si vince, la distribuzione degli incarichi la si fa in base ai voti delle liste affluenti e delle preferenze dei singoli concorrenti. Non è difficile trarre da tutto questo le debite e inevitabili conseguenze. Che contemplano persino accordi sottobanco con qualche avversario pur di far perdere il compagno di partito che sta per acquisire troppo potere.
Ripensare dunque alle leggi elettorali per eliminare la personalizzazione delle elezioni dirette e le contrapposizioni del maggioritario allo scopo di creare le condizioni che possano restituire agli eletti quella che dovrebbe essere la loro vera funzione politica, e per evitare che essi si curino solo di propaganda, o che siano trascinati dai leoni da tastiera o dagli influencer.
Un partito plurale?
Ma la personalizzazione e le contrapposizioni dei gruppi organizzati non riguardano solo le leggi elettoriali, riguardano anche la vita interna del PD.
Il PD si definisce partito plurale: è una definizione che si porta dietro la suggestione della modernità, il segno di un’accogliente disponibilità, di un’apertura verso posizione diversificate. Ma è proprio così? Non sembra: la realtà vera è quella di un partito diviso in correnti, in fazioni che si avversano per conquistare posizioni di potere e avere la possibilità di orientare le molte decisioni che si fanno nel sottobosco della politica. Con una ulteriore nota negativa: che quelle correnti solo vagamente si rifanno ad opzioni, a declinazioni di carattere squisitamente politico; spesso e volentieri sono soltanto aggregati di piccoli e grandi interessi, di gruppi che si mettono insieme per pura convenienza, disponibili a cambiare campo quando è più opportuno, e disponibili combattere l’avversario interno denigrandolo, con i mezzi tanto in uso nella vituperata stagione staliniana. Non è la dialettica di un partito che discute liberamente al proprio interno, è un’altra cosa.
Un partito è tale perché è una parte del tutto, perché non vuole rappresentare la società nel suo insieme, ma vuole rappresentare una comunità che, pur con sfumature e prospettive diversificate, aggrega interessi e persone che vanno nella stessa direzione, non è un coacervo di frammenti indipendenti portatori spesso di visioni del mondo completamente differenti.
Qualcuno dirà che vi sono stati splendidi esempi di partiti che, pur divisi in correnti, hanno a lungo prosperato. È vero, ma questa osservazione vale per il passato, per la Prima repubblica, quando le correnti, grazie al sistema proporzionale, alimentavano e portavano voti al partito, non ora, quando, al contrario, il bacino elettorale del partito viene utilizzato per fare le fortune di Tizio o di Caio. E, soprattutto, non vale per l’attuale fase, popolata da partiti capeggiati da dirigenze forti e autorevoli, con l’unica eccezione del PD che in quattordici anni ha cambiato sette segretari.
È possibile rimediare a questa situazione dandosi nuove regole e una nuova organizzazione? È molto difficile, perché, al di là delle contrapposizioni personalistiche e dei giochi di potere, all’interno del PD, io credo, convivono malamente visioni del mondo che rappresentano non soltanto sensibilità diverse, ma prospettive poltiche che vanno in direzioni antitetiche.
Senza superare il sistema correntizio e i personalismi che si annidano nell’attuale PD, e senza sciogliere quei nodi squisitamente politici che si nascondono dietro il quotidiano agire politico, sarà difficile dare le giuste risposte alle domande iniziali.
Il caso Moscardelli e la recente uscita dal PD di Latina della Zuliani non sono altro che gli esiti ultimi di grandi questioni politiche irrisolte.
Agostino Attanasio

News-24.it è una testata giornalistica indipendente che non riceve alcun finanziamento pubblico. Se ti piace il nostro lavoro e vuoi aiutarci nella nostra missione puoi offrici un caffè facendo una donazione, te ne saremo estremamente grati.