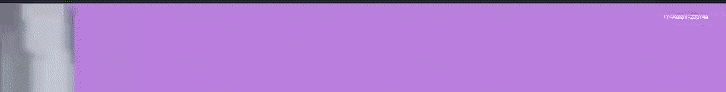– di Emilio Drudi
Passa anche da Ventotene la protesta degli esuli eritrei per la visita del presidente del
Consiglio Giuseppe Conte ad Asmara, dove ha incontrato Isaias Afewerki, il dittatore
che da oltre vent’anni ha trasformato il paese in uno stato prigione. Una protesta nata
non dalla visita in sé. Gli esuli, la resistenza contro il regime, comprendono bene che
uno Stato deve avere rapporti persino con una dittatura feroce come quella di
Afewerki. Il punto è il “come”. Come, cioè, vengono impostati e condotti questi
rapporti. Il Coordinamento Eritrea Democratica – il movimento che riunisce la
maggior parte dei gruppi di opposizione presenti in Italia – lo dice chiaramente a
Conte nella lettera che gli ha inviato alla vigilia della missione nel Corno d’Africa.
Ma gli dice anche di non dimenticare nemmeno per un attimo la terribile realtà del
Paese e gli chiede, dunque, di fare dei diritti umani, dei valori della nostra
democrazia e della nostra Costituzione, la guida da seguire nell’impostare questi
rapporti. Ed è qui, appunto, su questi valori, e, di contro, sulla mancanza totale di
libertà in Eritrea, sulla persecuzione di ogni forma di dissenso e, in particolare, sulla
sorte delle migliaia di prigionieri politici fatti sparire nelle carceri del regime, che
entra in gioco anche Ventotene. In una sorta di “ponte” tra antica e nuova resistenza.
Il “collegamento” lo offre la storia di Menghistu Ishak, un giovane originario di
Asmara che, perseguitato dal fascismo, ha concluso i suoi lunghi anni di confino
proprio a Ventotene, capolinea di una serie di trasferimenti che lo hanno portato a
conoscere le galere di Mussolini in mezza Italia.
L’arresto e poi la condanna al confino di Menghistu maturano nel 1936, durante
l’aggressione dell’Italia fascista all’Etiopia di Hailé Selassié, allora unico Stato
indipendente dell’Africa, con una storia millenaria, membro della Società delle
Nazioni fin dal 1929. La guerra è in pieno svolgimento. Una guerra – come si
scoprirà poi negli anni – condotta con l’uso massiccio di gas, bombardamenti
indiscriminati anche su obiettivi civili e, in definitiva, con una sorta di disprezzo
razzista dell’avversario, premessa delle leggi razziali che dal 1936/1937 hanno
introdotto una feroce apartheid in tutta l’Africa Orientale italiana: non solo in Etiopia
ma anche in Somalia e in Eritrea, che pure hanno fornito al Regio Esercito migliaia
di “ascari”, spesso usati come carne da cannone su tutti i fronti di combattimento, in
Abissinia come prima in Libia, durante la “riconquista” conclusa nel 1931.
Menghistu segue attentamente quanto sta accadendo in Etiopia dall’ottobre 1935,
quando sono iniziate le operazioni militari italiane, senza neanche una dichiarazione
formale di guerra. E’ un giovane colto e attento. Nato nel 1911 ad Asmara, viene da
una famiglia cosmopolita, di religione protestante e di tendenze liberali in politica.
Suo nonno, Tewolde Medhin, è stato il primo traduttore del Nuovo Testamento in
lingua tigré e tigrina presso la missione protestante svedese in Eritrea ed ha
collaborato alle ricerche di Carlo Conti Rossellini, uno dei più noti etiopisti italiani.
Il padre è un agiato coltivatore di caffè, con importanti rapporti d’affari in Europa. E’
proprio il padre a inviarlo in Italia giovanissimo per completare gli studi: nel 1928 si
diploma e l’anno dopo si iscrive alla facoltà di Ingegneria a Roma. Nel 1935, quando
scoppia la guerra, è alla vigilia della laurea e, da osservatore attento, non nasconde,
con amici e conoscenti, il suo disappunto, talvolta la sua rabbia, per l’aggressione
italiana all’Etiopia e per come i “fatti” del conflitto vengono presentati al Paese. Le
sue critiche non sfuggono alla polizia fascista.
Nel febbraio del 1936, poco dopo la battaglia del Tembien e all’indomani del
sanguinosissimo attacco al massiccio dell’Amba Aradam – durante il quale i cannoni
italiani spararono sulla linea del fronte quasi 23 mila colpi (comprese molte granate
caricate a gas arsina) e l’aeronautica sgancia ben 3.960 quintali di bombe –
Menghistu viene convocato dalla Questura: deve passare – gli dicono – nel
commissariato di zona per alcune comunicazioni, una questione di pochi minuti. Lui
non sospetta nulla. Si presenta e da quel momento non uscirà più dalle galere o dal
confino fascista, se non dopo il 25 luglio 1943. Non fa in tempo a sedersi, infatti, che
gli comunicano un ordine di fermo “per aver esternato accaniti sentimenti anti
italiani e anti fascisti”. In particolare, lo accusano di aver “gioito” per il massacro del
tenente Tito Minniti.
Quella del tenente Minniti, un giovane pilota dell’Aeronautica, è una delle tante
storie orribili della guerra in Etiopia. Di stanza nella base di Gorrahei, il 26 dicembre
1935 si leva in volo con il sergente Livio Zannoni per una missione di ricognizione
su Degehabur, un antico, importante nodo stradale nel sud dell’Etiopia, da cui
partono cinque strade carrozzabili in diverse direzioni, scelto come quartiere generale
per le sue truppe dal dejazmach Nasibu Emmanuel, uno dei comandanti militari del
governatore dell’Harar e del negus Hailé Selassié. Durante un passaggio a bassa
quota, il suo aereo viene colpito e costretto ad atterrare in territorio nemico.
Circondati dai soldati etiopi accorsi sul posto, i due piloti rifiutano di arrendersi,
difendendosi con il fuoco della mitragliatrice di bordo, nella speranza forse che
possano arrivare soccorsi da Gorrahei. Il sergente Zannoni è colpito a morte durante
lo scontro; Minniti, a sua volta ferito, viene preso prigioniero, torturato e decapitato.
La testa mozzata è poi infilzata come un trofeo su una lancia.
Questa fine orribile del giovane ufficiale (poi decorato con medaglia d’oro alla
memoria) desta ovviamente enorme impressione in Italia. Menghistu ha sempre
negato, però, di aver “gioito” per il massacro come gli veniva contestato: si è limitato
a dire, come sempre, che bisognava parlare non solo di quelli “etiopi” ma di tutti gli
orrori della guerra in corso. Guerra, peraltro, scatenata dal fascismo. Ma la sentenza
era già stabilita nel momento stesso della sua convocazione al commissariato: 5 anni
di confino. Trasferito subito nel carcere di Palermo, fa il giro delle principali “isole
confinarie” del regime: prima Ustica, poi le Tremiti e, infine, Ventotene. Per un
periodo di reclusione che via via si allunga: scaduti i primi cinque anni, infatti, la
condanna viene rinnovata di anno in anno perché nei diversi luoghi di detenzione si
rifiuta fare il saluto romano: “Reiteratamente diffidato a salutare romanamente – si
legge nei rapporti di polizia sul suo conto – si opponeva adducendo che le sue teorie
politiche non gli consentono di riconoscere come saluto doveroso quello fascista”.
A Ventotene, “l’università dell’antifascismo”, Menghistu arriva nell’aprile del 1938
In pochi giorni si conquista la fiducia di molti dei confinati e, in particolare, diventa
amico di Ernesto Rossi, uno dei padri del Manifesto Federalista, e di Sandro Pertini.
Liberato tra gli ultimi dopo la caduta del fascismo, riuscirà a tornare in Eritrea solo
nel 1945, a guerra finita, quando l’Italia ha perso ormai da quattro anni il suo
“impero” in Africa Orientale. E anche in Eritrea lo guida il suo senso di libertà: dopo
essersi schierato con il movimento che chiedeva la proclamazione di uno Stato
indipendente per l’ex colonia italiana, entra presto in contrasto con la politica
dell’Etiopia la quale, contrariamente al mandato delle Nazioni Unite del 1952, non
considera l’Eritrea una regione “federata” ma annulla via via tutte le forme di
autonomia, fino ad arrivare, nel 1960, a una vera e propria annessione, seguita da una
occupazione militare quando scoppia la guerra di liberazione. La resistenza che
porterà finalmente all’indipendenza nel 1991, dopo un conflitto durissimo durato
trent’anni, lo vede ovviamente tra le sue file.
Forse proprio a causa di questo infinito, sanguinoso conflitto, Menghistu torna in
Italia una volta soltanto, ma in una occasione importantissima: lo invita, nel 1980,
Sandro Pertini, il suo vecchio compagno di confino, diventato Presidente della
Repubblica. E’ un incontro memorabile, al Quirinale. E’ lo stesso Pertini a raccontare
la storia di Menghistu, con il quale ha diviso cinque anni di vita e di lotta a
Ventotene, e perché ha voluto chiamarlo in Italia. E sancisce poi tutta la stima che
nutre nei suoi confronti nella dedica scritta sulla foto che li ritrae insieme: “A
Menghistu Ishak, fiero antifascista, mio amico fraterno. Con profondo affetto”.
Nella loro lettera al premier Conte, gli esuli eritrei non fanno un riferimento specifico
alla storia di Menghistu. Preferiscono rammentare, più in generale, le responsabilità
che l’Italia si è assunta nel loro paese, fin da quando vi ha costituito la sua prima
colonia. “L’Italia – scrivono – ha antichi rapporti con l’Eritrea. Ma ha pure pesanti
responsabilità per quello che ha significato il dominio coloniale italiano nel nostro
Paese e più in generale in tutta l’ex Africa Orientale, specie durante il fascismo, ma
non solo. A nome del Coordinamento Eritrea Democratica, come soggetto politico
alternativo all’attuale regime, chiediamo a Lei, al Governo che rappresenta e
all’Italia intera di non ripetere certi grossi errori del passato, sia remoto che recente,
nei confronti del nostro Paese. E’ interesse di entrambi i nostri popoli – eritreo ed
italiano – trovare una nuova strada da percorrere insieme. E questa strada non è
certamente quella di chiudere gli occhi di fronte alla realtà o, peggio, di una
legittimazione, diretta o indiretta, della dittatura che ha reso schiavo e fatto del nostro
Paese uno stato-prigione”. Ma questo “richiamo generale” è solo il primo passo. A
poche settimane di distanza da quella lettera, la storia di Menghistu è stata al centro
di una manifestazione/rievocazione a Bologna, che promette di inaugurare una serie
di iniziative analoghe per ricordare altre vittime del fascismo e del colonialismo
italiano, ma anche gli errori della politica italiana del dopoguerra nel Corno d’Africa.
E la scelta di iniziare proprio da Menghistu non appare casuale: nel 1980 Pertini, il
presidente che più di tutti ha rappresentato i valori della nostra Repubblica, ha voluto
invitare e stringere la mano a un antico compagno eritreo che ha speso la vita intera
per la libertà; ora, nel 2018, a quasi quarant’anni di distanza, il presidente del
consiglio italiano è andato a stringere la mano a un dittatore come Isaias Afewerki,
“al buio”, senza cioè sollevare, per quanto se ne sa, alcuna seria pregiudiziale
irrinunciabile sul rispetto della libertà e dei diritti umani. Allora il messaggio sembra
evidente: in questo momento cruciale, l’Italia deve scegliere se schierarsi di fatto al
fianco del regime o rispettare i valori fondanti della sua Costituzione e di quella idea
d’Europa che è nata a Ventotene.
News-24.it è una testata giornalistica indipendente che non riceve alcun finanziamento pubblico. Se ti piace il nostro lavoro e vuoi aiutarci nella nostra missione puoi offrici un caffè facendo una donazione, te ne saremo estremamente grati.