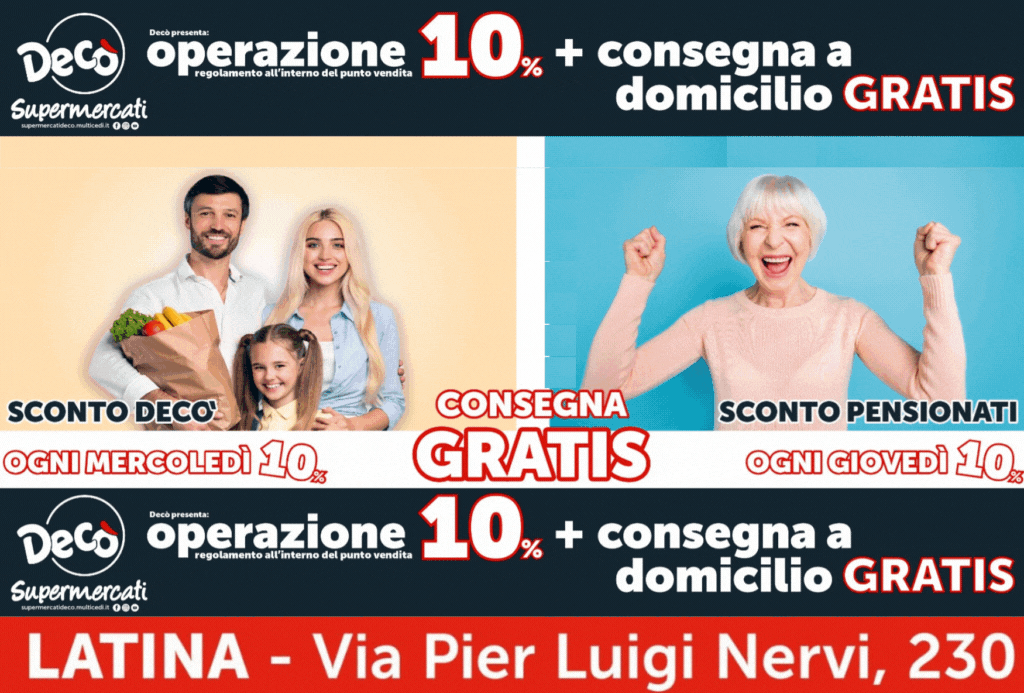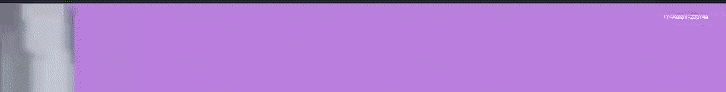Il simbolismo in concreto, secondo l’Enciclopedia Treccani, è “il complesso delle notazioni, dei simboli usati in una determinata scienza o disciplina”. Il caso che mi accingo a disquisire riguarda il simbolismo chimico, che risultò estremamente necessario quando la chimica dopo la scoperta delle leggi fondamentali si avviava a concretizzarsi in scienza. Il simbolismo doveva soddisfare esigenze di natura pratica, costituendo un linguaggio appropriato ed essenziale e un efficace presupposto euristico nella ricerca e nella didattica. Il primo ad ideare, usare e proporre universalmente i simboli degli elementi chimici conosciuti, che allora erano una trentina tutti con nome latino, e a dettarne le regole per l’eventuale scoperta di altri elementi, fu il chimico svedese Berzelius (1779 – 1848) nel 1813, aggiungendo nel 1815 la notazione che «I simboli chimici debbono essere delle lettere per spiegare quello che è scritto senza alterare la fisionomia di un libro stampato; per ciò io assumo come simboli degli elementi le iniziali del nome latino di ogni sostanza elementare …». E questo simbolismo ovviamente lo trovai, all’inizio dell’anno scolastico, quando entrai nella classe del primo liceo classico, inaspettatamente nella grande “tavola periodica degli elementi chimici” appesa in alto sulla parete dietro la cattedra. E quello stesso giorno, per caso, ci fu la prima lezione di chimica, premessa dell’intero programma, in cui la professoressa (laureata in farmacia) accennò ai simboli di quella tabella e del loro significato che mi apparvero in quel momento incomprensibili. L’unico significato che riuscii a captare era ciò che quei simboli stavano alla base di un nuovo linguaggio, quello chimico, in quanto essi costituivano un alfabeto nuovo e anche arcano, un mezzo attraverso cui si sarebbe potuta “scrivere” e rappresentare la composizione chimica di qualunque corpo vivente e non vivente e anche dell’intera terra e dei corpi celesti (tramite la spettroscopia). Parafrasando il filosofo tedesco Martin Heidegger (1889 – 1976) il quale sosteneva che Il linguaggio è la casa dell’essere e nella sua dimora abita l’uomo, si potrebbe affermare che “il linguaggio chimico è la casa di tutte le sostanze esistenti e di quelle non esistenti in natura, dove l’uomo può muoversi e agire liberamente senza alcun ostacolo”. Mi accorsi in seguito che quella conoscenza era soltanto una semplice ma essenziale informazione (dal latino in-formare significa dare forma a qualcosa), la quale non forniva gli strumenti per potere autonomamente e concretamente giungere alla finalità per cui era nata in primis la chimica, che poi si era evoluta assiomaticamente come scienza. Questo simbolismo quindi era elementare informazione con cui si dava “forma virtuale” agli elementi chimici, costituendo la premessa per approfondire e conoscere l’essenza di questa scienza che soltanto l’intero percorso degli studi universitari avrebbe potuto dare. E parafrasando il filosofo contemporaneo Luciano Floridi, l’informazione è un labirinto concettuale, in cui ci si può smarrire, perdere, disorientare se non si perviene alla consapevolezza dell’informazione ricevuta, ci si può rendere conto della causa che induce la maggior parte degli studenti degli istituti scolastici superiori a “disdegnare” la chimica.
Di ciascuno di quei simboli è necessario conoscere, rubando un termine alla linguistica, il rispettivo significato “semantico” (dal greco antico sêma, segno) relativo al significato delle relative parole, ovvero evidenziare la “conoscenza semantica”, corrispondente al significato sostanziale e profondo e anche invariabile degli elementi da essi rappresentati; in altre parole tutto ciò che rende esistente ognuno di essi. Lo scrittore Richard Bach, nel romanzo Bipiano (Rizzoli, 1977), infatti, scrive che ciò che conta non è il simbolo, ma il suo significato, non ciò che è al di fuori, ma ciò che accade dentro. Mi chiedevo, tuttavia, come fosse stato possibile isolare tutti quegli elementi riportati nella tavola periodica che, nel periodo storico in cui mi sedevo nei banchi del liceo, arrivavano al 103° (Laurenzio) e che oggi arrivano al 118° (Oganesson)? E non è finita qui in quanto, elaborando i dati disponibili relativi anche alle ricerche astronomiche, oggi si può prevedere di arrivare al 164° elemento. “Di questi ultimi elementi super pesanti, infatti, le possibili sorgenti sono le esplosioni di Supernovae (l’esplosione stellare di una Supernova è più energetica di una Nova), che accadono 1-2 volte per secolo nella nostra galassia, oppure le collisioni tra coppie di neutroni stellari e coppie di buchi neri di recente scoperta, che mettono in stretta relazione l’astronomia con la chimica”.
Se adesso si volesse usare il linguaggio simbolico e avviare la via della conoscenza semantica basterebbe prendere come esempio, nella tavola periodica degli elementi, la casella del primo elemento, l’idrogeno, simbolo H, ed entrare nei dettagli. Nella casella si nota che al di sopra e al di sotto del simbolo sono indicati rispettivamente il numero intero 1, noto come numero atomico che deriva dall’unico protone presente nel nucleo (il numero atomico corrisponde al numero di protoni, particelle di carica elettrica positiva, presenti nel nucleo dell’atomo di ogni elemento), e la massa atomica relativa (u.m.a.) a cui nel recente passato si dava il nome di peso atomico: essa esprime il rapporto tra la massa assoluta dell’atomo e la massa dell’entità presa come riferimento, cioè 1/12C12. Nella stessa casella, sulla destra dall’alto verso il basso del simbolo, sono indicate la temperatura di fusione (°C) e quella di ebollizione (°C), quindi l’energia di ionizzazione (kJ/mol) e l’elettronegatività. Tutti i valori corrispondenti sono caratteristici dell’elemento idrogeno e per questo essi costituiscono le proprietà dell’idrogeno. Tutto ciò detto vale per ogni casella della tavola periodica in cui è riportato il simbolo di un elemento. Metaforicamente ogni casella rappresenta la carta di identità dell’elemento ivi indicato. Ovviamente senza entrare nello specifico sperimentale che richiederebbe un intero corso di laurea, in questa sede è sufficiente sapere che esistono dei metodi analitici relativi a ciascun elemento che permettono di liberarlo dagli altri elementi costituenti il composto, o sostanza composta, a cui esso è legato in natura e misurarne le proprietà elencate, verificando tramite il criterio di invarianza (v. link: https://www.soc.chim.it/sites/default/files/users/sci_didattica/Dal-modello-macroscopico-al-modello-microscopico.pdf ) che esse risultino corrispondenti a quelle riportate in tabella. Sarà l’invarianza delle proprietà fisiche nel tempo che farà dedurre che sia stato isolato l’elemento chimico studiato a cui sarà dato il nome specifico. Ogni elemento chimico è una sostanza semplice non decomponibile in altre sostanze. Esso si distingue dalle sostanze composte, costituite da più elementi secondo un proprio rapporto quantitativo, per le quali si applica lo stesso criterio di invarianza, in quanto anche esse sono sostanze pure caratterizzate da intrinseche proprietà.
Francesco Giuliano
News-24.it è una testata giornalistica indipendente che non riceve alcun finanziamento pubblico. Se ti piace il nostro lavoro e vuoi aiutarci nella nostra missione puoi offrici un caffè facendo una donazione, te ne saremo estremamente grati.